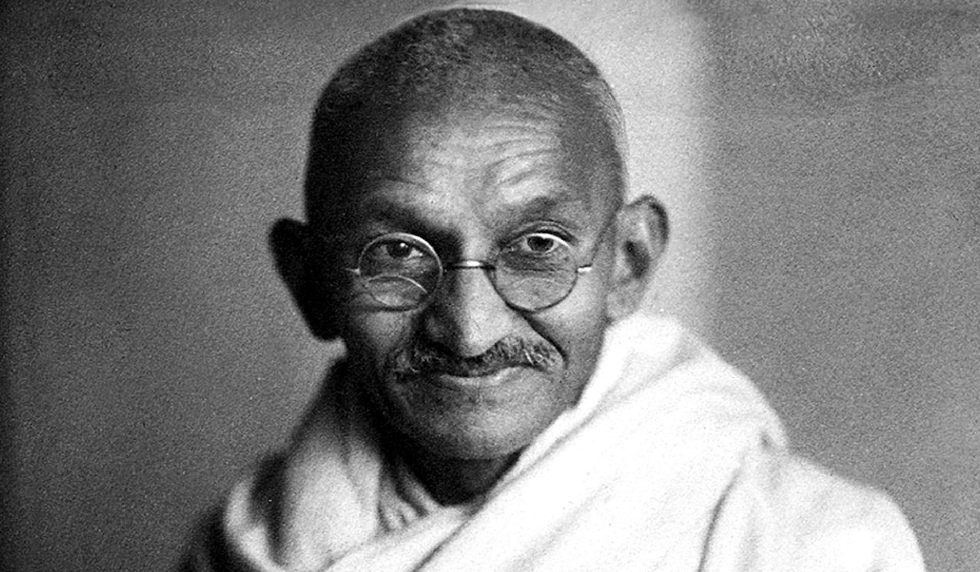in questi giorni di guerra ho ritrovato un breve racconto che avevo scritto tempo fa. Parla di come finisce una guerra, o almeno di come è finita quella del 14-18… all’undicesima ora, dell’undicesimo giorno, dell’undicesimo mese.

” Titic-tic…tic…”
Nel vagone di 2a classe ora adibito ad ufficio, due giovani dattilografi attendono come pulcini nel nido che l’ufficiale capoturno – un anziano colonnello di fanteria – depositi loro nel becco le parole del documento. Fuori ha ripreso a piovere; solo la linea degli alberi accenna il confine tra la terra di guerra e il cielo di novembre, grigio come la ghisa.
Foglio 13, paragrafo XXXIV… “La durata dell’armistizio è fissata in 36 giorni con facoltà di essere prolungato…”. L’Ufficiale scandisce ogni sillaba con un accento della Dordogna che si arrampica vittorioso su quel francese burocratico.
“Tic- tic- tic…”
Il treno l’aveva voluto il maresciallo Foch, il comandante supremo degli eserciti alleati in Francia. Con quello si spostava avanti e indietro alle spalle di un fronte lungo più di 800 chilometri e comandava. Comandava a milioni di uomini di uscire dalle loro trincee e iniziare a correre fino a quelle tedesche. Poche centinaia di metri, a volte solo decine, poi la mitragliatrice li avrebbe falciati come grano in giugno. La Somme, Verdun, Le Chemin de Dammes, Ypres…erano i nomi di questa immensa mietitura di uomini. Ora il treno è fermo nella foresta di Compiegne, non lontano dalla stazione di Rethondes. Sull’altro binario, a neppure cento metri è fermo un altro treno, quello della delegazione tedesca che dovrà firmare quei fogli che finalmente metteranno fine a quel raccolto.

Il treno di Foch, come lo chiamano tutti, si compone di una carrozza ristorante, la n. 2418 D per l’esattezza, una carrozza letti, la n. 1888, e la carrozza salone n. 2443. Ad esse sono stati aggiunti altri due vagoni bagagli per le scorte e materiali vari.
Agli inizi di ottobre del ’18 il ministero della guerra aveva ordinato al Direttore della Compagnia dei Vagoni Letto di allestire ad ufficio una vettura ristorante a due sale: nella sala più grande, quella di 1a classe, avrebbe dovuto lasciare due tavoli da quattro posti e uno più grande tavolo sul quale poter aprire mappe e carte; nella sala più piccola, quella di 2a , avrebbero sistemato due tavoli-scrittoio e qualche sedie; infine nella vecchia cucina i fornelli sarebbero stati sostituiti da tre tavoli per le macchine da scrivere. Era da lì che veniva quel ticchettare che il mondo attende da quasi cinque anni. Per i dattilografi chini sulle loro “Contin de luxe – Paris” quelli sono i fogli più importanti della loro vita. Non ci possono essere errori. Nessuna correzione, nessun graffio di gomma.

“Perfetto!” il colonnello dall’isopprimibile accento di Dordogna preme sui fogli i timbri previsti, li registra nel protocollo della posta in uscita e infine li sistema ciascuno in una cartella di cartone rigido color fango. Tre grappette tengono ferme le parole che separano la vita dalla morte. Gettato un ultimo sguardo s’incammina rapido verso la carrozza 2419D. Lo stanno aspettando.
“Tieni. Mettili alla firma e facciamola finita”. Dice porgendo le cartelle al giovane tenente della coloniale incaricato di sistemare il tavolo. Avrà si e no vent’anni e non riesce a celare un sorriso. Suo fratello Jaques è ancora in qualche buca fangosa dalle parti di Saint Omer. Spera sia ancora vivo.

“… Il presente armistizio è stato firmato l’11 novembre 1918 alle ore…”. Il colonnello alza gli occhi verso orologio a muro, è sempre andato avanti di tre minuti, un rapido calcolo e completa a penna “…5 (cinque), ora francese”.
Sul fronte occidentale, nelle trincee, nei ricoveri pieni di pidocchi, nelle postazioni di vedetta riempite di fango il cessate il fuoco entrerà dunque in vigore quel giorno stesso: all’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese dell’anno.
Fuori fa freddo. E’ l’inizio dell’inverno, il quarto di guerra; 1560 giorni trascorsi da milioni di uomini nell’angoscia di non sapere se quello che hai appena fatto sarà il tuo ultimo respiro.
Sulla foresta di Compiegne, a qualche chilometro dalla stazioncina di Rethondes, i primi raggi di un sole gelido filtrano dai vetri della vettura 2419 D. Alle cinque della mattina dell’11 novembre la delegazione tedesca ha firmato quei fogli. I plenipotenziari tedeschi erano quindi scesi dalla carrozza incamminandos verso il loro treno che li avrebbe riportati…non sapevano neppure loro dove. A Berlino nessuno rispondeva più al telefono. Per quel che ne sapevano, la Germania poteva già non esistere più.
Anche sulle Ardenne fa un gran freddo ma Augustin ride. Ride e vorrebbe saltare, urlare, ballare. Dal comando di battaglione hanno comunicato che la guerra è finita e lui sta correndo in linea per avvertire che alle 11,30 ci sarà minestra calda per tutti. E vino. Vino per tutti. Augustin attraversa le case distrutte di Vrigne sur Meuse, passa la ferrovia che collega Sedan a Charleville o quel che ne resta. Guarda l’orologio, manca meno di mezz’ora alla fine della guerra e ride. Non lo sente neppure arrivare. Un proiettile Spitzer calibro 7.92 lo prende in piena fronte.

George Lawrence ha 26 anni e non è mai stato in Europa, a dire il vero non è mai stato da nessuna parte oltre i campi di casa sua. Del Belgio conosce solo il canale di fronte a lui e un ponticello semi diroccato. Per lui Mons non è una città, ma solo macerie, terra smossa e odore di morte. Niente a che vedere con l’aria pulita e odorosa di alberi del Canada. Prima di quella pazzia collettiva faceva il contadino in Nuova Scozia e adesso è soldato semplice nel 28° battaglione fanteria canadese, matricola 256295. Non una grande carriera. Quel giorno è un lunedì e a lui è toccato di andare di pattuglia verso il canale, in rue de Mons…hanno detto che la guerra è finita, ma è meglio stare attenti, lì è pieno di crucchi.
Neppure lui sente arrivare il suo proiettile.
Augustin Trébuchon dalla Francia, George Lawrence Price dal Canada; Henry Gunther dagli Stati Uniti: George Edwin Ellison del 5° Royal Irish Lancers e altri 2738 uomini moriranno nell’ultimo giorno di guerra senza vedere l’undicesima ora, dell’undicesimo giorno, dell’undicesimo mese.
Per tutti gli altri la guerra è finita.